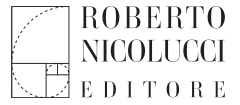Stefano Causa – Dischi da correre
Brutta cosa l’invidia.
Se diamo credito al Sommo Poeta, il caro papà Dante che da quelle parti racconta di esserci stato, agli invidiosi – lì nel Purgatorio – ci legano le palpebre col fil di ferro e ce li tengono a cantare le litanie dei Santi, vestiti col cilicio finché l’anima non sia emendata. Ora, passi per il cilicio e, seppur fastidioso, il fil di ferro sulle palpebre; ma le litanie dei Santi per tutta quella fetta di Eternità, proprio no! Poffarbacco!
Quindi, nel tentativo di mondarmi pubblicamente dall’ennesimo mio difetto, mostrando a tutti la sincerità del mio pentimento, nella speranza di acquistare, a suo tempo, una possibilità di benevolenza agli occhi di un qualsivoglia Giudice che dovesse trovarsi nella noiosa incombenza di dover sentenziare sul cumulo delle mie mancanze terrene, proverò a parlarvi nel modo più corretto e sincero e per quelle che sono le mie limitate capacità, dell’oggetto del mio (ultimo in ordine di tempo) rigurgito di invidia: questo volume, a titolo “Dischi da correre” di Stefano Causa.
E, il motivo dell’invidia, non è tanto nella piacevolezza e nell’indubbia validità del libro in questione, ma in quello che, a mio avviso, esso significa.
Cercherò di spiegarmi.
Conosco Stefano Causa da molto più tempo di quanto mi faccia piacere di tenerne il conto, ma – seppure mi piacerebbe il poterlo affermare e, ne sono certo, lui non avrebbe da ridirne – non credo sia il caso di annoverarmi tra i suoi amici, ché troppo sporadica e frammentaria è stata, nel tempo, la nostra frequentazione (quindi, almeno il dubbio che, con questa mia, si possa incorrere in qualsivoglia forma di “conflitto di interessi” dovrebbe essere fugato). Di lui, Storico dell’Arte, professore universitario, curatore di Mostre ed animatore culturale di primo piano non solo a Napoli ed in Campania, autore di libri ed articoli ed, insomma, intellettuale di vaglia riconosciuto in ambito non solo nazionale, potrete trovare (se ne aveste voglia) abbondanti notizie in rete; io – di mio – posso solo aggiungere che, chi abbia avuto la fortuna ed il privilegio di assistere a qualcuna delle sue lezioni, ne serba ancora il vivido ed illuminante ricordo.
Ma Stefano, oltre a tutto questo ed altro di cui – qui – non mette punto parlare, ha da sempre anche un’altra passione, un amore neanche tanto nascosto: la Musica.
E, così, il Nostro se ne viene fuori bel bello con questo ben curato volume per i tipi della Roberto Nicolucci Editore, che è, né più né meno, che un succulento e gustosissimo trattato sulla Musica Pop nell’accezione più ampia ed inclusiva del termine. O meglio: più che un trattato è un viaggio, un percorso a ostacoli, una mappa per perdersi, il fantasma di un romanzo di formazione o, più semplicemente (ma solo all’apparenza), la presentazione di una lista di dischi da cui e su cui far partire una serie di dialoghi su presente, passato, Arte, vita vissuta e altre quisquilie.
Ma – e qui sta il coup de théâtre, l’idea illuminante – Causa, che sa bene che “parlare di Musica è come ballare di architettura”, di quei dischi non ci dice quello che ci aspetteremmo ma ci parla delle copertine!
E quelle copertine ci sono tutte, tutte quelle che ci devono essere e molte che non ti aspetteresti, ma – soprattutto – non ci sono quelle che “non devono esserci”: tipo “Sgt. Pepper” o la banana di Warhol o altra roba che saresti sicuro di trovare in un libro di un Castaldo qualunque o di un Assante. Ecco, qui non c’è quel tipo di roba da “manuale del bravo critico musicale” qui si parla d’altro: ad esempio, che il bianco è il colore del ’68, che nelle cattedrali come in certi dischi è meglio entrare dalle porticine laterali, di che cosa accumuna Tina Turner in tubino nero a papa Paolo III Farnese o il prog più evoluto ai dentisti, di quanto sappiano sedurre le volpi vestite di rosso e che Dickens avrebbe dovuto saper suonare il flauto traverso, per non dire del fare pipì in compagnia sui nostri riti & miti e anche di molto, molto altro.
Il tutto, poi, portato per strade sconnesse che passano da Totò a Hitchcock, da Lucia Canaria a Proust, da Egon Schiele all’Acchiappa giochi di Rai YOYO e poi per paghette, vacanze-studio, feste danzanti e Oriette Berti alla TV.
Insomma, altro che Alto e Basso, qui siamo “oltre”! In un frullatore che viaggia nei cieli di “altroquando”; perché è di questo che parliamo quando parliamo di Arte: di estasi e di ascelle sudate, di libri letti in grigie sale d’attesa ed epifanie abbaglianti apparse in maleodoranti vagoni di treno, in scomodissime poltroncine di scafatissimi cineforum o, magari, in concerti dove tutti tossivano oppure mentre cercavamo di rubare un bacio sotto un palco tra spintoni e calci e anche di lunghi silenzi in musei vuoti; insomma di pinzellacchere e quisquilie che ti riempiono la Vita (e, talvolta, te la salvano).
E non si faccia l’errore (o peggio il torto) di scambiarlo per un divertissement, una deviazione di percorso, per i 5 minuti d’aria di un affermato intellettuale che cerca di distrarsi dalle ponderose incombenze del suo ruolo. No, “Dischi da correre” è perfettamente coerente con il resto della – solo apparentemente diversa – produzione letteraria del Nostro Autore, da “La strategia dell’attenzione” a “Caravaggio tra le camicie nere” (per dire dei primi due che mi sento di consigliare a chi ama essere stupito da questi temi) con i quali condivide ben più che la felicità del linguaggio e la profonda conoscenza della materia trattata.
Insomma, per tornare all’incipit di questa mia e per dire di quel “significato” da cui nasce la malevolenza della mia invidia, ecco: “Dischi da correre” è il libro di qualcuno che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno! Di chi sa quello che “nessuno sa ed in pochi dicono: ma la storia dell’Arte moderna è una questione di copertine – canale altamente navigabile che, per segmenti popolari, diventa un’autentica corsia preferenziale” e ce lo dice.
E, per sovraprezzo, lo fa divertendosi e divertendoci. Alla faccia di chi, ancora, crede che la cultura (quella con la “K” maiuscola) debba essere un fatto di “sudate carte”.
Ma, per restare al nostro àmbito, ché qui – tra di noi – siamo tra poppettari e vecchi campioni di “air-guitar”, aggiungo che Causa è la Alman Brothers Band o i Grateful Dead: inutile provare a portare in studio quello che sanno essere “dal vivo”, se non li hai visti in concerto ne puoi godere solo a metà (parafrasando una nota pubblicità), e questo “Dischi da correre” è il suo “Anthem of the Sun”, cioè il tentativo, più o meno riuscito, di avvicinarsi il più possibile a quello che avveniva sul palco. Così, se non te lo immagini dietro lo scranno di professore a dire quelle stesse cose saltabeccando dalle canzoni di Sade alle crocefissioni di Francis Bacon sotto lo sguardo stupefatto dei suoi allievi, te lo godi – appunto – solo a metà; anche se “metà is megl che nient” (per parafrasarne un’altra, di pubblicità).
Infine, dopo aver sottolineato rapidamente anche l’ultima chicca, e cioè che il volume non ha la canonica forma rettangolare ma è quadrato (scelta non certo commercialmente pagante, direi), proprio per non deformare o rimpicciolire e umiliare quelle copertine che, uniche vere protagoniste del lavoro, vengono riprodotte tutte rispettando colori e rapporti originali (e se questo non dimostra quanto seriamente il Nostro autore si sia approcciato alla materia, non saprei in che altro modo dimostrarlo), vado ad indossare un ruvido maglione di lana e, ad occhi chiusi, intonerò litanie di Santi.
Così, giusto per cominciare ad allenarmi.
Non si sa mai.